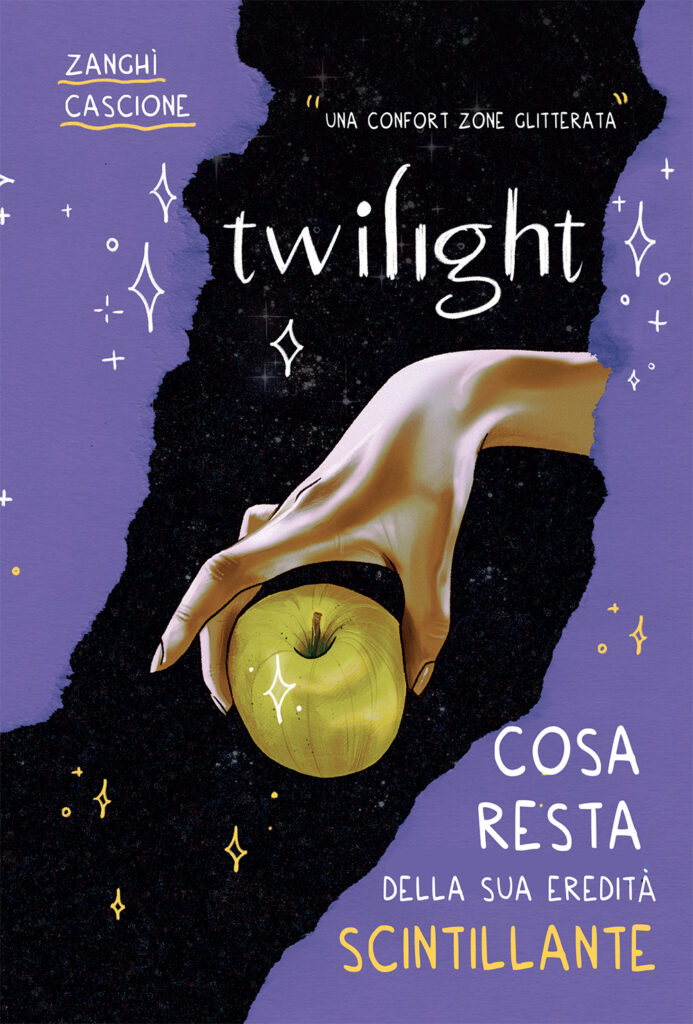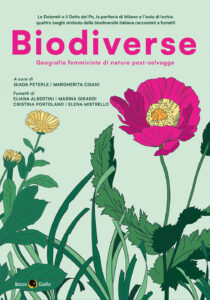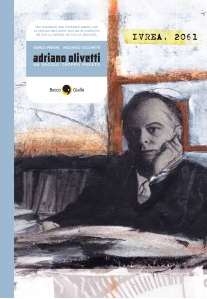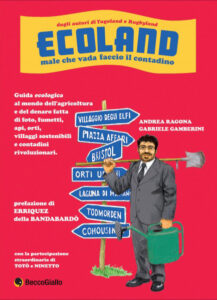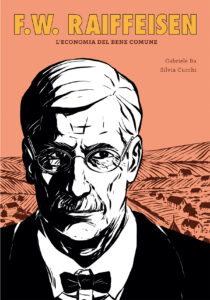La prima volta che sono andata al Lucca Comics & Games avevo 17 anni, sono andata in giornata con mia mamma, con un pullman organizzato dalla fumetteria della mia città.
Per me era stato meraviglioso: le cose che mi piacevano e che non sapevo con chi condividere, ora venivano celebrate da migliaia di altre persone. Mia madre invece era un po’ confusa, non capiva perché accanto a noi ci fosse seduto Naruto.
Perché per me era stato così importante quel giorno? Vedere che le mie passioni – anche se nella loro forma più addomesticata e commercializzata – potevano avere uno spazio, un luogo, è un ricordo che mi ha cresciuto nel tempo, e ora, 10 anni dopo, mi ritrovo al rientro da Lucca con ancora addosso l’emozione dei giorni appena trascorsi, con la valigia piena di fumetti nuovi ancora da svuotare: ho guardato le nuove uscite, le ho sfogliate, ho immaginato dove mi avrebbero potuto portare, mi sono chiesta cosa avrebbero raccontato, ho incrociato gli autori e le autrici che lasciano andare nel mondo le loro storie, ho chiesto ai miei amici e alle mie amiche cosa volessero andare a vedere quest’anno, quali libri, quali case editrici, ho intravisto i fili che tessono questa realtà a tutte le altre possibili, già vicinissime, e ho provato a rivelarle per guardare dove ci potrebbero portare.
Quest’anno a Lucca, BeccoGiallo, tra le varie novità, aveva un libro su Twilight. Che senso ha fare un saggio su una saga come questa? Le storie ci insegnano a stare in queste contraddizioni: a celebrare la nostalgia per un prodotto che allo stesso tempo consideriamo terrificante e problematico da veramente quasi ogni punto di vista. Ma di cosa siamo nostalgici, esattamente? A cosa riesce a riportarci, persino una storia come questa?
Twilight è stato insieme un fenomeno di massa e un bersaglio culturale (piuttosto facile), ma anche uno dei primi passi per molte persone verso la possibilità di costruire un immaginario comune, uno spazio di appartenenza; per molte e molti è stata magari la prima volta che ci si è scoperti capaci di provare affetto verso dei personaggi.
Nonostante i continui tentativi di riassorbire le storie, di renderle concilianti, di farle diventare solo spazi performativi (e di acquisto), le storie straripano, e i mondi contenuti al loro interno riescono a fuggire, a non farsi catturare; riescono a superare il loro ruolo di “specchio” o di rappresentazione, diventando luoghi di vera elaborazione, della ricerca di un senso che scorre in tutte le biografie, in tutti i luoghi che abbiamo conosciuto e osservato da uno spiraglio anche di poche pagine. Nella letteratura c’è tutta la potenza delle trame antiche che ci precedono, del rimosso culturale, generazionale, c’è una melma che va attraversata e che non può semplicemente “lasciarci al sicuro”, perché le storie non sono (solo) rassicuranti, ma contengono un enorme potenziale sovversivo.
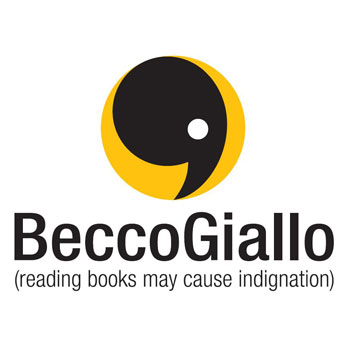
Come donna, ho cercato per anni narrazioni che fossero in grado di non restituirmi un’immagine di me che alla fine fosse solo questo: docile, vulnerabile e impotente, rassicurante (anche nel suo pensarsi sfuggente, evasiva).
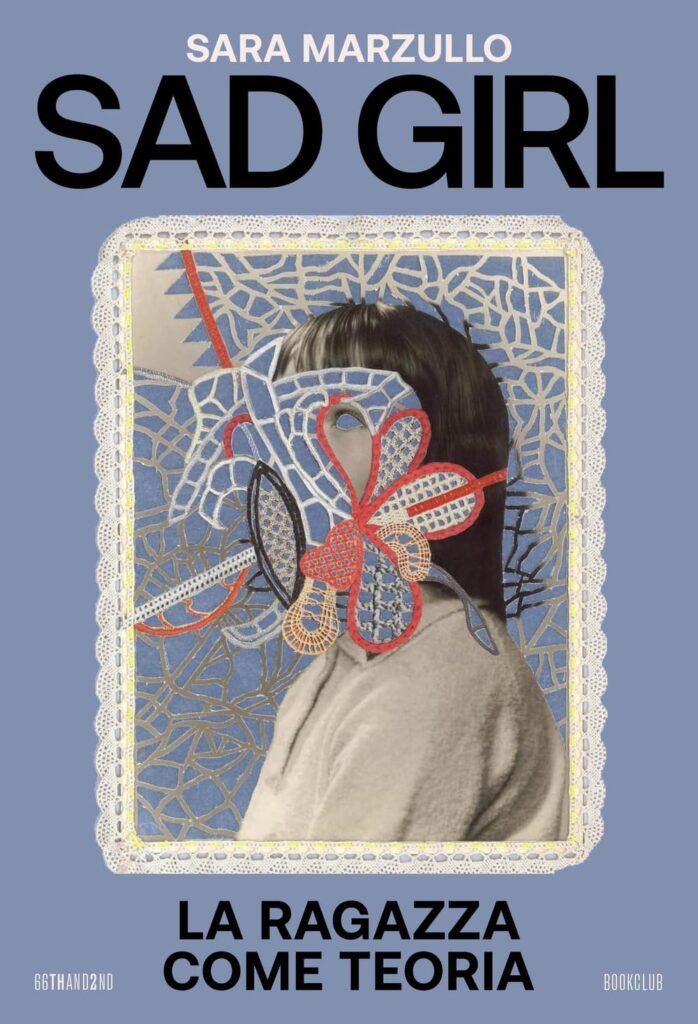
Per approfondire, sia il tema della rappresentazione femminile nei prodotti culturali degli ultimi decenni, ma anche intorno alle comunità online di ragazze che costruiscono un’identità – e spazi identitari – intorno a una certa narrazione di “ragazza”, consiglio il testo “Sad Girl. La ragazza come teoria” di Sara Marzullo, pubblicato nel 2024 per 66thand2nd.
No, non è stata Bella Swan a darmi questa storia, ma non sono state neanche le donne dei classici che per anni mi hanno fatto leggere e rileggere a scuola (a me Stephenie Meyer ha rovinato la vita tanto quanto “Salinger e compagnia bella”, cit. “Sputiamo su Holden”, un podcast di Mariella Martucci). Ho iniziato a sentire e sviluppare la necessità di una narrazione scoprendo l’entusiasmo che altri e altre avevano già trovato appassionandosi a storie, saghe, serie, fumetti, graphic novel.
Per molti, il primo passo verso questa scoperta è avvenuta appunto tramite i grandi colossal, come è stato per me (Il Signore degli Anelli, Harry Potter, e poi tutta quella roba pensata e cucita apposta per me, FEMMINA, cioè cose come Twilight). A volte, però, i cerchi si chiudono e poi riescono anche a saltare in aria: e così è stato, che a 20 anni dall’uscita del primo libro della saga di Twilight sono tornata a rivederlo al cinema, ed è stato forse questo momento di condivisione (con i miei amici e le mie amiche, in una sala che rideva, applaudiva) a risignificare quell’abisso di senso che era stato Twilight. Lo riguardavamo, e intanto vedevamo scorrere davanti a noi tutte quelle immagini che al tempo non avevamo compreso nella loro gravità. Rimane dell’amaro in bocca a pensare che sono quelle le narrazioni che ci hanno cresciuto: per anni abbiamo faticato alla ricerca di storie che ci sapessero davvero raccontare, e poi non solo quello, che ci mostrassero quello che in tutti giorni sfugge, rimane ai margini, nascosto. Le storie producono e riproducono costantemente immaginari, e quando questi si riscoprono invecchiati male e consumati (non che all’inizio brillassero chissà quanto…), li possiamo però risignificare noi, che è quello che mi sembra essere successo in quella sala del cinema, dove tanti puntini, tante storie arrivate dopo, sono state in grado persino di risignificare quello sgradevole prodotto che è Twilight
In particolare consiglio il video della youtuber Contrappoints: “Twilight”
Lo possiamo ripensare, rielaborare, affezionarci e insieme prenderne le distanze (anche se veniamo pensate come troppo ingenue per essere capaci di fare un tale lavoro critico). È quello che le persone fanno da sempre, i fan ricreano e reinventano continuamente le storie che amano, le riscrivono, interpretano, ne fanno fanfiction, video, meme: è un modo di abitare le storie stesse.
Sulle fanfiction e sul “lavoro dei fan”, c’è un’interessante newsletter su Substack di Eresie Etiche:
Le nostre fanfiction, il vostro guadagno? di Zeno de Belvis
Una prospettiva fandomica sull’uso che le compagnie di IA (e non solo) fanno del lavoro di noi fan.
Leggi su SubstackEd è quello che succede nel libro Twilight: cosa rimane della sua eredità scintillante. Davvero, cosa rimane?
Come potevamo non renderci conto di cosa ci stava dicendo un film del genere quando mostrava cose come: maschi che continuano a ribadire di avere un problema con il controllo (stile “se sorpassi il limite potrei non controllarmi”, mettendoci davanti agli occhi una coppia felicissima, dolcissima, dove la donna ha il viso sfregiato dal suo compagno per colpa dei suoi “problemi di gestione della rabbia”), dove a un gruppo di uomini indigeni viene ripetuto che “puzzano di cane”, dove tutte le ragazze (a meno che non siano particolarmente interessanti perché vampire, licantrope) vengono rappresentate come delle sciocche e frivole, o comunque descritte solo tramite gli effetti che provocano, quindi senza autonomia, con il solo compito di ammaliare, far impazzire gli uomini. È tutto così sbagliato. Ma anche tutto così… onesto? Non credo sia necessario fare il discorsetto in cui spiego che non è colpa di Twilight se a 15 anni pensavo (pensavamo) che un uomo dovesse entrarmi in camera di nascosto e guardarmi dormire per farmi capire che mi amava.
Due domande a Chiara Gregori

In Twilight vengono raccontate come romantiche varie pratiche che trovo piuttosto disturbanti (se non moleste o violente, in alcuni casi). Eppure, qualcosa per anni mi ha fatto davvero sperare di vivere una storia d’amore come quella, con quel tipo di intensità. Questa cosa, o situazioni simili ma più specifiche intorno a delle specifiche “fantasie sessuali” che mi sembravano disturbanti, hanno prodotto poi in me un certo senso di vergogna, ma anche di inquietudine. Ho voluto fare due domande su questo tema a Chiara Gregori, ginecologa e sessuologa che con noi ha pubblicato: La sessualità spiegata ai bambini e alle bambine, Per Piacere. Piccola guida per una sessualità consapevole, Io sono Io e Oggi mi sento una favola!. Per noi ha inoltre curato due libri tradotti dall’estero: È solo endometriosi! e La sostituta.
Nei tuoi libri tocchi il tema delle fantasie sessuali e dei desideri: come si distinguono e come stanno in tensione fra di loro? C’è altro oltre la polarità “agire una fantasia” oppure “reprimerla”?
Trovo importantissima la domanda riguardo la differenza tra desideri e fantasie erotiche, perché se riuscissimo davvero a chiarirci su questa grande differenza e sull’importanza di entrambe, potremmo stare meglio con la nostra sessualità. E, visto che è vero che la sessualità è un atto intimo, ma poi come portiamo in giro il nostro corpo e la nostra sessualità è anche un atto politico, allora chiarirci su questo diventa un atto di cura verso la nostra comunità.
A me non piacciono le suddivisioni troppo granitiche e calate dall’alto, appellandosi a una scienza che “ha necessariamente ragione”, però sappiamo che una macro differenza c’è, evidenziabile proprio a livello neuroscientifico, perché sono infatti diverse aree del cervello quello coinvolte quando stiamo fantasticando e quando invece stiamo desiderando, programmando, sognando in termini di piani per la vita. La parola “sogno”, nelle sue diverse accezioni, interviene in entrambi i casi.
La fantasia erotica fa parte della dimensione del sogno, nel senso onirico, ed è un lasciare andare la mente dove ha bisogno di andare, dove sta meglio e si sente al sicuro. È proprio quella la funzione delle fantasie erotiche: permettere al corpo di lasciarsi andare all’eccitazione, al piacere e al possibile raggiungimento dell’orgasmo, nonostante possano esserci pensieri disturbanti come “Non sono all’altezza”, “Non sono capace”, “L’altra persona non starà bene con me”, “Si sta adattando”. Pensieri ovviamente non eccitanti, eppure la nostra mente ha trovato degli escamotage per riuscire ad accantonarli. Si dice spesso che per potersi lasciare andare non ci vogliono pensieri, e quindi come si fa? I pensieri non si possono scacciare a calci, ma li possiamo disattivare dedicando la nostra attenzione alle fantasie erotiche. Questa è, secondo me, una breve spiegazione della differenza tra qualcosa che desideriamo fare – che programmiamo e immaginiamo di poter agire rendendola possibile – e quando invece ci stiamo lasciando andare a una dimensione onirica che serve a non far interferire i pensieri con il momento erotico.
Per quanto riguarda la polarità “agire la fantasia vs reprimerla”, in generale viene proposto: “se sei abbastanza coraggioso o spavaldo la agisci; altrimenti la reprimi”. In realtà entrambe le cose non vanno bene. Agire una fantasia erotica può essere turbante, perché le fantasie possono avere contenuti molto spregiudicati, e che nel momento in cui vengono agiti rischiano di mortificarci invece che di eccitarci come facevano nella nostra mente. Ma anche reprimerle non serve. Ciò che viene negato può poi agire a livello inconscio – tanto più se compresso – ed emergere con un “pilota automatico” e portarci a compiere azioni che non siamo in grado di modulare. Quindi no: entrambe le polarità non vanno bene. È bellissimo potersi lasciare andare alle proprie fantasie sapendo che non ci stanno dicendo chi siamo, non stanno plasmando la nostra personalità né ce la stanno raccontando. È tutta un’altra cosa, un altro ambito. Sarebbe molto lungo spiegare perché c’è chi ha determinate fantasie e chi ne ha altre.
Spesso ci colpevolizziamo per le fantasie che abbiamo, ci sembrano delle depravazioni. Hanno anche delle origini che ci superano, queste fantasie (magari storiche o culturali?) E’ possibile viverle in armonia e far in modo che non siano fonte di senso di colpa ma piuttosto di benessere (sessuale ma non solo)?
Una risposta breve non si riesce a dare: c’è bisogno di stare con le persone, per raccontare quanto sia importante essere fedeli a se stesse e a se stessi, vicini a sé, fidarsi di sé e prendersi cura di sé anche sotto questo aspetto, con l’amorevolezza che serve davvero per non agire poi cose spaventose.
Nel momento in cui le nostre fantasie ci disturbano molto, parlarne con qualcuno è prezioso: ci può aiutare a collocarle dentro di noi. Ci sono sempre più persone competenti anche in materia, anche se può capitare di incappare in qualcuno che non lo è. Quindi è importantissimo non prendere come oro colato ciò che ci viene detto, ma potrebbero arrivare spunti interessanti.
Certamente, anche chi ha fantasie erotiche che possono sembrare più “depravate” non è una persona depravata. Però dovremmo parlarne in modo molto più specifico. Nei miei libri – sia ne La Sessualità spiegati ai bambini e alle bambine che in Per Piacere – ho provato a raccontare alcune di queste caratteristiche, per dare degli elementi. Dire più di così in modo specifico rischia di essere invadente, perché proporre esempi di fantasie erotiche può turbare: c’è chi può essere disturbato da certe fantasie, o in un senso o nell’altro, perché le sue non sono così, o perché le sue sono considerate “peggio” in termini di depravazione.
In generale, possiamo assolutamente non essere giudicanti verso noi stesse e noi stessi nel momento in cui ci viviamo le nostre fantasie.
Twilight riproduce una realtà già ben strutturata, lo fa impegnandosi quel minimo che basta ad aggiungerci qualche glitter in più, ma non si sforza di parafrasare quasi nulla. Le donne sono raccontate da sempre come creature che vanno protette, e che possono essere le protagoniste delle nostre storie solo se sono “meno femminili possibili”, diverse, eccezioni. Bella non spettegola, Bella legge Jane Austen. Ci mancherebbe pure, per carità. E io a 13 anni guardavo Twilight, a 28 lo riguardo al cinema, ne parlo, lo rielaboro con le mie amiche, fuori dalla sala chiacchieriamo e ci raccontiamo cosa stiamo leggendo ora, perché è anche dal bisogno più ingenuo di condivisione che riesce a farsi spazio e a risorgere una necessità vera e materiale di condividere immaginari, racconti. Le storie per fortuna ci trascendono e sanno infilarsi ovunque, sanno prendersi spazio. Ci vuole tempo*.
*E un sistema scolastico ed educativo capace di uscire dai canoni occidentali ed eteronormati che spesso riproducono dinamiche violente e coloniali, e luoghi culturali sostenibili e accessibili, che possano sostenere le persone e le comunità che li animano.
Le storie, i mondi e i personaggi che le abitano, sanno creare legami che possono superare il concetto di fandom, non perché sia un concetto malato di per sé, ma perché è spesso ridotto al fatto che è tutto misurato con il suo potere d’acquisto, o perché finisce spesso per diventare un gruppo fortemente identitario (soprattutto se riesce a intercettare l’isolamento, e può generare in forme che sì si politicizzano, ma in modo regressivo).
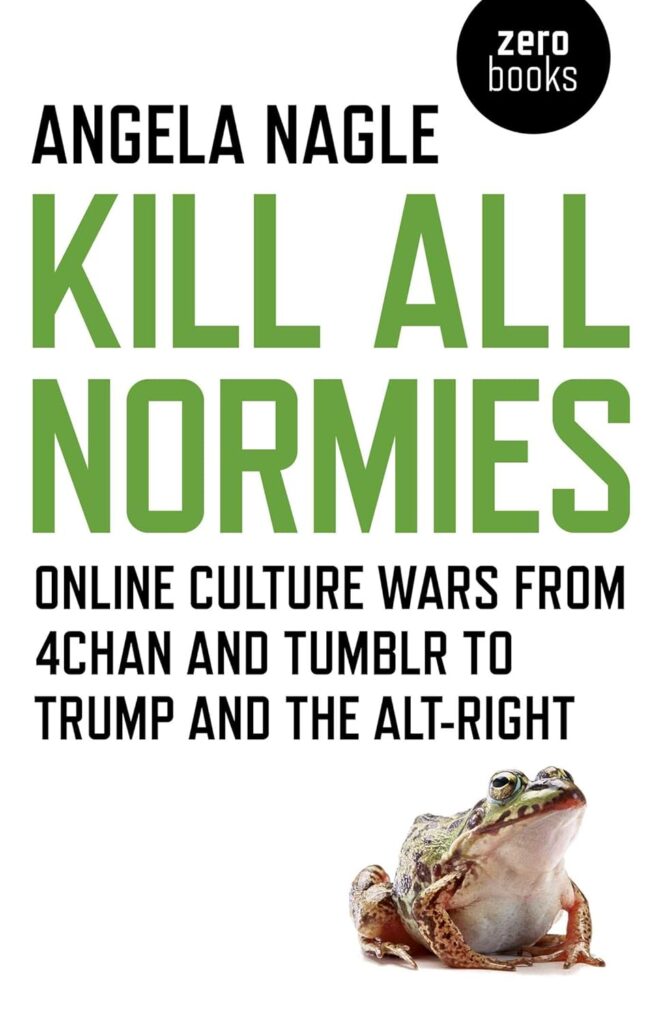
Per approfondire: “Kill All Normies” di Angela Negle, purtroppo attualmente non disponibile in italiano
Nei fandom, inoltre, viene spesso riprodotto un binarismo rigidissimo: ci sono dei fandom pensati e costruiti (o meglio, sono costruiti a monte i prodotti e pensati rispetto al solo consumo che ne verrà fatto) proprio per uno specifico target “femminile” (che tendenzialmente viene delegittimato per i suoi gusti e accostato da aggettivi come: isterica, infantile, ingenua; le “fangirl” non sicuramente come “esperte” del settore, a differenza magari dei gamer).
Possiamo far saltare in aria, con le storie stesse – non lasciandole appassire alla loro stessa mercificazione – queste identità, questi binarismi, possono superare un concetto di comunità che sia solo “safe” (e che cerca solo conferme di sé e riconoscimento): c’è una gioia materiale dietro tutto questo, che spiazza, trasforma, e lo fa quotidianamente, lo fanno l* autor*, l* lettor*, chi fa gruppi di lettura, incontri, chi si autoproduce le proprie opere, le case editrici che provano a far sopravvivere degli spiragli di mondi sulla carta. Le storie ci permettono di soggettivarci, di mostrarci che ci sono infiniti modi, non in luoghi impossibili, non in un futuro lontanissimo, ma già infiltrati nel presente che viviamo e che ha bisogno di essere osservato e raccontato.
Se ci chiediamo che senso ha fare un libro su Twilight, siamo proprio costretti a chiederci che senso ha fare un libro in generale, ma la risposta esiste se pensiamo le storie come alcuni fra gli ultimi luoghi dove ci è ancora concesso di immaginare alternative, dove ci viene insegnato a essere ricettivi verso ogni forma di vita.
Le Guin vedeva la narrativa come allenamento politico dell’immaginazione, cioè la possibilità di pensare mondi non ancora esistenti: la fantascienza con lei assume la forma non tanto di un racconto che vuole prevedere il futuro, ma che ci mostra che il presente può essere immaginato diversamente.
E l’immaginazione non è evasione, ma ci fa guardare il nostro presente e ce lo rivela – per davvero, non come unica realtà possibile. Ogni storia che amiamo ci chiede, in fondo “e se fosse possibile vivere diversamente? Se fosse possibile stare insieme diversamente, attraverso il tempo, gli spazi, in altri infiniti modi?”
In appendice, rimandiamo a un po’ di libri del nostro catalogo che fanno i conti con questi altri “mondi possibili”, o raccontano storie di chi ha provato a muoversi all’altezza di queste domande.

Redattrice, correttrice di bozze, dispensatrice gratuita di ansia nella redazione padovana.
Questo articolo è stato scritto per:
Immagine di copertina: Claudio Calia